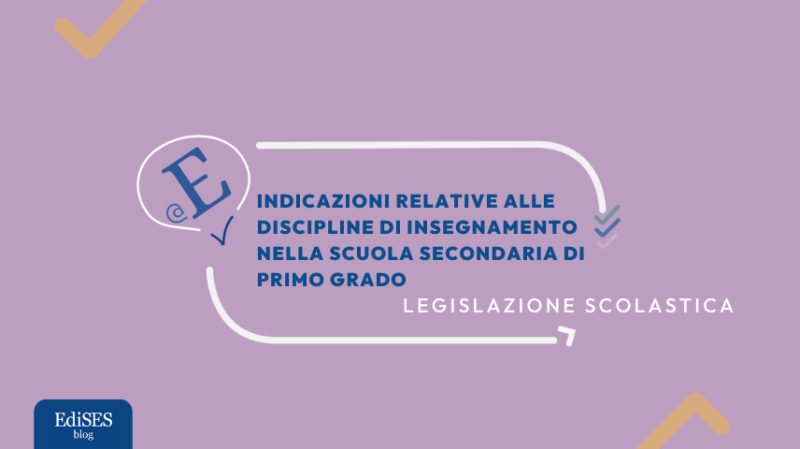È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026 il decreto n. 221 del 9 dicembre 2025, che adotta le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Gli argomenti dell'articolo
L’entrata in vigore delle nuove Indicazioni nazionali
L’art. 1 del Regolamento ne prevede l’entrata in vigore a partire dall’a.s. 2026/27, con le seguenti puntualizzazioni:
- le previgenti Indicazioni nazionali continuano ad applicarsi per le classi intermedie di scuola primaria e secondaria di primo grado già funzionanti nell’a.s. 2025/26, fino alla conclusione dei rispettivi corsi ma i collegi dei docenti dovranno avviare una rielaborazione graduale del curricolo di istituto;
- nell’a.s. 2027/28, le classi terze di scuola primaria ne anticipano l’adozione limitatamente alla disciplina “storia”.
- l’insegnamento del latino per l’educazione linguistica (LEL) può essere avviato a partire dalle classi seconde e terze funzionanti nell’anno scolastico 2026/27.
Le Indicazioni del 2012 continueranno a valere per le classi intermedie già attive nell’anno scolastico 2025/26, fino alla conclusione dei rispettivi cicli e cesseranno definitivamente di avere efficacia in tempi diversi:
- dall’a.s. 2026/27 per l’infanzia,
- dal 2028/29 per la secondaria di primo grado
- dal 2030/31 per la primaria.
La struttura delle Indicazioni nazionali 2025
Il testo definitivo si compone di 103 pagine (a fronte delle 154 della prima stesura): una consistente e Il testo definitivo è leggermente più snello rispetto a quello della prima stesura di marzo 2025 (una semplificazione frutto, anche, dei suggerimenti del CSPI) e si apre con le Premesse culturali alle Indicazioni nazionali. Queste ultime sono articolate nei seguenti punti:
- Persona, scuola, famiglia. Questa sezione evidenzia come il concetto di persona, da associare ad ogni singolo fanciullo, alunno o studente, comprenda in sé tre dimensioni fondamentali che sono inseparabili: l’identità, la relazione, la partecipazione. Si sottolinea inoltre l’alleanza educativa tra Scuola e Famiglia: la crescita del bambino/alunno/studente è affidata ad una comunità educante che si compone di tre attori principali: la scuola, con il ruolo svolto dai docenti, la famiglia, con la funzione fondamentale dei genitori, e la comunità, nella quale riconosciamo diversi soggetti incaricati di compiti e funzioni;
- Scuola e nuovo umanesimo. In questa sezione, la scuola, dal segmento dell’infanzia fino al primo ciclo, viene descritta come un percorso verticale che punta all’acquisizione di conoscenze e abilità di base per costruire competenze culturali nei tre ambiti cardine – umanistico, scientifico e tecnologico – in una prospettiva di formazione integrale. La vera svolta concettuale è il modo in cui si definisce il talento: nell’accezione proposta nelle 2026, il talento non è una qualità innata e statica, ma è un obiettivo da perseguire, attraverso un percorso che costruisce conoscenze e abilità nello studente e permette la maturazione delle competenze di base.
Successivamente alle Premesse sopra richiamate, la struttura delle Indicazioni nazionali 2025 si compone di due parti principali:
- Finalità della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo di istruzione
- le Indicazioni nazionali vere e proprie: per la scuola dell’infanzia e per le scuole del primo ciclo.
Qualche cenno a ciascuna di esse.
Finalità della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo di istruzione
Si afferma che la scuola italiana, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese in quanto:
- assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (art. 34 Cost.), elevati a dieci a seguito della legge n. 296/2006;
- agisce in collaborazione con la famiglia (art. 30 Cost.), nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.);
- nella progressione dei suoi tre gradi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) contribuisce in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresenta un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) ed è centrato sull’autonomia funzionale delle scuole (art. 117 Cost.):
- la libertà d’insegnamento si realizza all’interno di una professionalità docente responsabile, guidata da vincoli deontologici chiari, tra cui la trasparenza valutativa, la collegialità e l’impegno per l’inclusione;
- con l’autonomia, le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo all’interno del quadro delle norme generali cui devono attenersi tutte (statali e paritarie).
Con le Indicazioni Nazionali sono individuati il Profilo dello studente, gli Obiettivi generali del processo formativo, gli Obiettivi specifici di apprendimento e le relative Competenze attese per ciascun campo di esperienza / disciplina, unitamente alla proposizione delle Conoscenze.
Il profilo dello studente
Il profilo dello studente descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che uno studente dovrebbe dimostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.
Le competenze al termine del primo ciclo di istruzione
L’elenco delle competenze deriva dal D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024 con integrazioni tratte dalla Raccomandazione Europea 22 maggio 2018 C 189/01, dal Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e dal Framework DigComp 2.2.
Esse sono:
- competenza alfabetica
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Gli obiettivi generali del processo formativo
Gli obiettivi del processo formativo rappresentano la declinazione operativa delle competenze indicate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo.
Organizzati per aree e articolati per ciascun grado scolastico, gli obiettivi generali sono lo strumento fondamentale di guida per l’annuale progettazione educativo-didattica collegiale del consiglio di classe, la formulazione del sintetico giudizio intermedio e finale sul grado di sviluppo della maturazione complessiva dell’alunno, la certificazione delle competenze dell’alunno alla fine di ognuno dei due gradi scolastici.
In questa parte delle Indicazioni nazionali, le competenze sono declinate tramite le Tabelle dedicate agli Obiettivi generali al termine della scuola primaria e agli obiettivi generali al termine della scuola secondaria di primo grado.
L’organizzazione del curricolo di scuola
Gli obiettivi del processo formativo rappresentano la declinazione operativa delle competenze indicate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo.
Organizzati per aree e articolati per ciascun grado scolastico, gli obiettivi generali sono lo strumento fondamentale di guida per l’annuale progettazione educativo-didattica collegiale del consiglio di classe, la formulazione del sintetico giudizio intermedio e finale sul grado di sviluppo della maturazione complessiva dell’alunno, la certificazione delle competenze dell’alunno alla fine di ognuno dei due gradi scolastici.
In questa parte delle Indicazioni nazionali, le competenze sono declinate tramite le Tabelle dedicate agli Obiettivi generali al termine della scuola primaria e agli obiettivi generali al termine della scuola secondaria di primo grado.
Le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia
Sono mantenuti i cinque “campi di esperienza”: ‘Il sé e l’altro’, ‘Il corpo e il movimento’, ‘Immagini, suoni e colori’, ‘I discorsi e le parole’, ‘La conoscenza del mondo’.
I “campi di esperienza” furono introdotti per la prima volta dagli Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali (D.M. 3 giugno 1991) per indicare gli “ambienti del fare e dell’agire del bambino” e i “settori specifici ed individuabili di competenza”. Rimangono attuali, infatti, le ragioni pedagogiche legate al riconoscimento dell’esperienza infantile nei diversi ambienti di vita come terreno di costruzione di saperi e di maturazione delle competenze personali sul piano sensoriale-percettivo, emotivo-affettivo, cognitivo, linguistico-espressivo, psico-motorio, sociale, morale, religioso, nel rispetto dell’unitarietà dello sviluppo.
Questa parte delle Indicazioni si conclude con il paragrafo “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria”, che illustra le competenze attese nel passaggio alla scuola primaria.
Le Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo di istruzione
Le discipline di insegnamento
Per sapere quali siano le discipline di insegnamento previste nelle scuole del primo ciclo occorre rifarsi al Per sapere quali siano le discipline di insegnamento previste nelle scuole del primo ciclo occorre rifarsi al Regolamento di “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (D.P.R. n. 89/2009), e precisamente:
- per la scuola primaria si ha il rinvio al precedente assetto, frutto del D.Lgs. n. 59/2004 e del correlato D.M. 31 luglio 2007 che ha emanato le prime Indicazioni nazionali;
- per la scuola secondaria di primo grado, all’art. 5, c. 5, del D.P.R. n. 89/2009 è riportato il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado.
Di conseguenza, così recita l’art. 2, c. 2, del Regolamento: “Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 che disciplina l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, il tempo scuola e i modelli orario della scuola primaria, l’orario annuale obbligatorio e il quadro orario settimanale e annuale delle discipline della scuola secondaria di primo grado.”
Nel medesimo articolo, al c. 1, è riportato l’elenco delle discipline di insegnamento nel primo ciclo: italiano, lingua inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, tecnologia, scienze, musica, arte e immagine, educazione motoria per la scuola primaria ed educazione fisica per la scuola secondaria di primo grado.
Lo schema di presentazione adottato nelle nuove Indicazioni nazionali
Nella formulazione delle Indicazioni nazionali, il testo ministeriale si attiene, per la presentazione di ciascuna delle discipline, allo schema seguente:
| Nome della disciplina – Perché si studia | ||
| scuola primaria | – competenze attese al termine della classe quinta – obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe terza – obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta -conoscenze | |
| scuola secondaria di primo grado | – competenze attese al termine della classe terza – obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe terza – conoscenze |
Il paragrafo introduttivo della trattazione di ciascuna disciplina (“Perché si studia …”) evidenzia l’importanza attribuita all’aspetto motivazionale del lavoro dei docenti e dell’impegno degli studenti.
Latino per l’educazione linguistica (LEL)
L’innovazione è stata oggetto di discussione, sia negli ambiti professionali che nel pubblico dibattito.
Le motivazioni del LEL sono date nel paragrafo “Perché si studia il latino” e possono ritenersi sintetizzate nel seguente passaggio: “il LEL aspira a comunicare e rafforzare la consapevolezza della relazione storica che lega la lingua italiana a quella latina e a rendere evidente come il latino costituisca un’eredità condivisa e un elemento di continuità tra le diverse culture europee, così da far maturare la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea plasmata da una pluralità di esperienze culturali che hanno mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in termini di continuità, ora di reinterpretazione, ora anche di opposizione.”
Sulle modalità attuative, il Regolamento (art. 2, c. 3) prevede due tappe:
- iniziale, durante la quale l’insegnamento del LEL può essere avviato utilizzando gli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell’offerta formativa
- in attesa dell’integrazione del quadro orario settimanale e annuale della scuola secondaria di primo grado (a modifica dell’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009).
Strumento musicale
Nei percorsi ad indirizzo musicale della secondaria di primo grado, la nuova sezione delle Indicazioni nazionali relativa all’insegnamento dello strumento musicale va a sostituire quella indicata nell’Allegato A del D.M. 1° luglio 2022, n. 176: quindi, nessun rilievo sotto il profilo ordinamentale.
L’istruzione integrata matematico-scientifico-tecnologica (STEM)
Le Indicazioni nazionali insistono sulla necessità di adottare un approccio che metta in relazione matematica, scienze, tecnologia, arte e discipline umanistiche.
In prima battuta, l’insegnamento delle discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche concorre a potenziare il pensiero critico e creativo degli alunni, sostenendo lo sviluppo delle loro capacità di intuizione, analitiche e di modellizzazione, offrendo strumenti per porre e risolvere problemi e per affrontare situazioni di diversi livelli di complessità.
E’ altrettanto importante evidenziare che tali discipline sono parte integrante del patrimonio culturale dell’umanità e che contribuiscono all’evoluzione del pensiero umano in quanto:
> consentono di acquisire una prospettiva storico- culturale su di esse
> permettono di comprendere come la matematica, le scienze e la tecnologia siano state influenzate e abbiano influenzato la società e i suoi mutamenti.
Infine: la polemica sulle Indicazioni nazionali di Storia
“Solo l’Occidente conosce la Storia”: così l’incipit del paragrafo iniziale “Perché si studia la storia”.
Si è accesa la polemica, con l’attribuzione alle Indicazioni nazionali dell’accusa di eurocentrismo, nazionalismo ecc.
In un articolo pubblicato sul Corriere della sera del 24 marzo, Ernesto Galli della Loggia, storico, già docente della Scuola Normale di Pisa e coordinatore del gruppo di lavoro che ha curato tale sezione delle Indicazioni nazionali, chiarisce il significato della proposizione.
L’espressione «solo l’Occidente conosce la storia» («conosce», non «ha») lungi dal significare «solo l’Occidente ha avuto una storia e tutti gli altri no», significa ciò che nelle frasi immediatamente successive del documento viene a lungo spiegato. Vale a dire che solo in quell’area geo-storica che si chiama Occidente la conoscenza dei fatti storici e la riflessione su di essi — alimentata dal pensiero greco-romano e dal messaggio cristiano — ha dato vita a una dimensione culturale particolarissima nella quale il realismo analitico più crudo si è mischiato al profetismo sociale più estremo. “Solo l’Occidente conosce la storia» non vuol dire che non ci sia stata un storia del Giappone o dell’impero Inca, e che quindi coloro che hanno sottoscritto queste parole siano dei tali idioti (per giunta un gruppo di storici di professione!) da aver mai pensato una simile corbelleria.”
Sul versante di coloro che criticano tale impostazione, appare significativa l’intervista a Carlo Ginzburg, anche lui (come Galli della Loggia) storico ed ex docente della Scuola Normale di Pisa, intervista pubblicata su La Stampa del 15 luglio.
“Quello che mi interessa in queste Indicazioni, al di là dell’ideologia che le ha generate, che ovviamente non condivido, sono le sue conseguenze. Quello che mi ha colpito subito è la rimozione del colonialismo, delle sue conseguenze e di ciò che significa oggi. Dire che “la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzi tutto intellettualmente padrona del mondo, di conoscerlo, di conquistarlo per secoli e di modellarlo”, senza precisare che oggi viviamo in un mondo in cui la centralità dell’Europa è completamente scomparsa, mi pare molto grave.”
Di seguito i link per accedere ai testi dei due autori, la cui lettura può accompagnare quella del testo ministeriale:
> Ernesto Galli della Loggia: l’articolo sul Corriere della sera del 24 marzo
> Carlo Ginzburg: l’intervista su La Stampa del 15 luglio