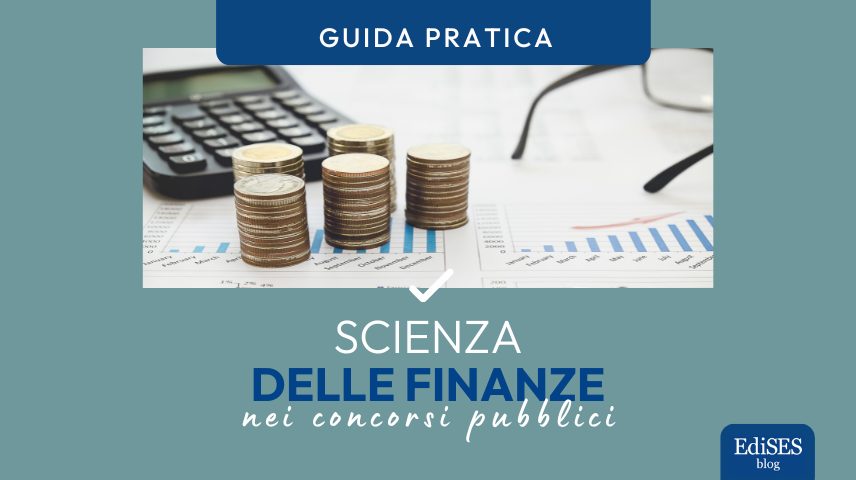La Scienza delle finanze studia l’attività finanziaria pubblica, cioè quell’insieme di regole e princìpi alla base di tutte le azioni che lo Stato e gli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) pongono in atto al fine di reperire le risorse necessarie all’erogazione dei servizi pubblici.
L’oggetto di studio della scienza delle finanze, così come al giorno d’oggi delineato, è frutto degli eventi storici e sociali susseguitisi nell’arco del ventesimo secolo e che hanno dato forma agli Stati nazionali e democratici, come noi li conosciamo. Volendo rintracciare nello specifico alcuni argomenti di studio della disciplina può essere utile assumere come riferimento teorico l’analisi di Musgrave sull’attività dello Stato, distinguendo tre funzioni:
- allocativa, concernente l’allocazione delle risorse tra i diversi possibili utilizzatori
- distributiva, concernente la distribuzione delle risorse tra gli individui, anche in connessione con i territori, i settori e le funzioni
- della gestione macroeconomica, che si riferisce all’impiego delle diverse parti del bilancio e del debito pubblico al fine di influenzare l’andamento macroeconomico tanto nel breve quanto ne lungo termine
Gli argomenti dell'articolo
Quanta scienza delle finanze si deve conoscere per i concorsi pubblici
La Scienza delle finanze è di per sé una materia dai confini poco definiti e spesso gli argomenti si intrecciano o travalicano in altre materie affini. Molti manuali in commercio trattano, quindi, anche temi poco afferenti alla materia.
Spulciando, però, i programmi dei vari bandi di concorso emerge chiaramente che lì dove è richiesta la conoscenza della scienza delle finanze sono presenti anche le materie ad essa affini. Ovviamente, a seconda del tipo di concorso al quale si partecipa è possibile che sia necessaria la conoscenza esclusiva di “elementi” o “nozioni” di scienza delle finanze mentre in altri si esige una conoscenza approfondita della materia, che a volte è indicata sotto la dicitura di economia pubblica o analisi delle politiche pubbliche.
In particolar modo, bisogna far caso alla presenza, nel programma di concorso, del diritto tributario, materia in cui spesso si ritiene che la scienza delle finanze sconfini. Quando il diritto tributario è espressamente richiesto dal bando, è chiaro che se ne esige una conoscenza approfondita che esula dal suo rapporto con la scienza delle finanze e che richiede lo studio nel nostro compendio di diritto tributario, quando invece non è presente nel programma indicato dal bando, allora sarà sufficiente l’infarinatura del sistema tributario, presente nel nostro compendio di scienza delle finanze.
Un altro fattore da tener presente è la presenza o meno di argomenti, che normalmente si studiano nell’ambito della scienza delle finanze, come discipline richieste autonomamente dal bando di concorso; ad esempio il sistema pensionistico o l’applicazione di tributi (Irpef, Iva ecc.) spesso sono specificamente previsti dal bando. In questo caso sono argomenti che vanno studiati in modo più approfondito.
Gli argomenti chiave
Tra gli argomenti più richiesti in sede concorsuale nell’abito della scienza delle finanze si possono indicare in prima analisi le motivazioni teoriche alla base dell’intervento dello stato in economia e i fallimenti del mercato.
Tra gli studi dell’intervento statale in economia spiccano le principali teorie economiche quali quelle della finanza neutrale, della finanza della riforma sociale, della finanza congiunturale e della finanza funzionale e la già citata teoria della finanza pubblica di Musgrave.
Riguardo ai fallimenti del mercato, sarà bene soffermarsi sulla definizione di bene pubblico, sulle asimmetrie informative (moral hazard e adverse selection) e le esternalità.
Con non meno frequenza sono sottoposti quesiti sul bilancio dello Stato e sulla spesa pubblica, con particolare riguardo al sistema pensionistico. Dal lato delle entrate, inoltre, è necessario un ripasso approfondito della teoria dell’imposta e dell’incidenza.
La prova preselettiva e la prova scritta: quesiti a risposta chiusa o aperta
Nei concorsi pubblici la valutazione della conoscenza di una materia è normalmente effettuata tramite prove a quiz, almeno nelle prime fasi del concorso.
Nelle preselezioni la regola è quella dei quesiti a risposta multipla, con la classica domanda corredata da 3 o 4 alternative di risposta.
Indicazioni su come prepararsi e su come affrontare al meglio tali prove sono fornite in modo dettagliato in diversi articoli di questo blog a cura del professore Marco Bonora.
Per affrontare le prove a test dei concorsi pubblici leggi i consigli del prof. Marco Bonora
Nelle prove scritte la scelta ricade normalmente sui quesiti a risposta aperta. Si tratta di una domanda cui deve seguire una breve illustrazione dell’istituto compendiata in poche righe (orientativamente circa 15/20). Normalmente le domande sono estremamente generiche e in teoria potrebbero avere delle risposta anche di più pagine. Ma bisogna fare molta attenzione perché non si tratta di un tema, ma di quesiti a risposta aperta; la difficoltà è proprio quella di dimostrare di avere un quadro chiaro di tutti gli aspetti dell’istituto senza tuttavia utilizzare intere pagine per spiegarlo.

Ecco un esempio di quesito a risposta aperta tratto dal MiniManuale di Elementi di scienza delle finanze:
Cosa si intende per asimmetrie informative e quali sono le due principali forme riscontrabili nel mercato?
La concorrenza perfetta presuppone che tutti gli operatori siano perfettamente informati riguardo ai prezzi ed alle quantità scambiate sul mercato. Tuttavia, l’informazione è una risorsa scarsa e distribuita in modo non omogeneo fra gli agenti economici. È molto probabile, quindi, che si verifichi una situazione di asimmetria informativa nella quale il mercato non opera in modo efficiente. Può avvenire, cioè, che i consumatori non siano informati riguardo la qualità dei beni scambiati e che, quindi, i produttori vendano a prezzi elevati beni di scarsa qualità. Questa situazione induce i consumatori a ritenere che la probabilità di acquistare beni di scarso valore ad un prezzo elevato sia alta e, quindi, si asterranno dall’acquistare i beni più pregiati. La produzione di questi ultimi, allora, diverrà poco conveniente anche per quelle imprese che, onestamente, puntavano alla qualità. Queste ultime ripiegheranno sulle produzioni di bassa qualità di modo che i prodotti scadenti rimpiazzeranno totalmente quelli di qualità: ci troviamo di fronte ad un fallimento del mercato.
Nella realtà le asimmetrie informative si presentano particolarmente in due tipologie:
- > adverse selection (selezione avversa). È il caso in cui, a causa di una distribuzione asimmetrica delle informazioni, poiché non si è in grado di valutare la reale qualità dei beni offerti, si innesca una progressiva penalizzazione dei prodotti di migliore qualità, avviene cioè, una “selezione al contrario”;
- > moral hazard (azzardo morale). È la situazione di asimmetria informativa in cui un soggetto, esentato dalle eventuali conseguenze economiche negative di un rischio, si comporta in modo diverso da come farebbe se invece dovesse subirle. Nel mercato delle assicurazioni, ad esempio, il comportamento del soggetto assicurato non può essere osservato dall’assicuratore. La non osservabilità dell’azione spinge l’assicurato a essere meno prudente rispetto a un soggetto non assicurato che, quindi, in caso di incidenti, non gode dei vantaggi dell’assicurazione.
La prova orale
La scienza delle finanze ricompare spesso anche nelle fasi finali di un concorso pubblico, quando si deve sostenere la prova orale. A questo punto più che ripassare di nuovo tutti gli argomenti l’attività più utile che si può fare è quella di “fissare i concetti”, vale a dire tracciare un quadro schematico di tutti i punti fondamentali della materia.
Questa operazione si può fare mentalmente, ma risulta ancora più utile ed efficace se viene fatta su carta, tracciando e organizzando una mappa concettuale. Nel MiniManuale di Elementi di scienza delle finanze questo lavoro è stato già fatto per voi. Alla fine di ogni capitolo del volume, infatti, sono presenti mappe concettuali (Percorsi riepilogativi) di tutti i capitoli del libro.
Scarica un esempio di Mappa concettuale

Scarica il file gratuito
Per uno studio completo e mirato: videocorso online
Oltre al minimanuale, per una preparazione integrata e lineare, Edises Formazione mette a disposizione anche il videocorso online di Scienza delle Finanze.
Cosa offre il videocorso?
- 11 videolezioni registrate, curate da un docente esperto che guidano lo studente attraverso tutti i temi chiave della disciplina con un approccio chiaro, graduale e immediatamente applicabile alle prove concorsuali.
- Slide riassuntive e dispense PDF organizzate per argomenti per consolidare i concetti appresi a lezione.
- Quiz di autovalutazione, che permettono di verificare l’apprendimento in tempo reale.
- Software di esercitazione in omaggio per allenarsi in condizioni simili a quelle d’esame.
- Tutoraggio dedicato assicura supporto continuo per chiarire dubbi e colmare eventuali lacune.
Grazie alla struttura modulare e alla durata di 12 mesi, il corso consente di studiare con flessibilità, riascoltare le lezioni quando necessario e consolidare progressivamente ogni argomento, garantendo una preparazione completa, organizzata e perfettamente calibrata sulle esigenze dei concorsi pubblici.
Il corso è disponibile al prezzo speciale di €39,90.
La preparazione in Scienza delle Finanze rappresenta uno snodo decisivo per chi aspira a superare con successo i concorsi pubblici, soprattutto quelli più selettivi come il recente bando pubblicato dal MEF.
Affrontare la materia con strumenti affidabili, aggiornati e strutturati in modo chiaro fa la differenza tra uno studio dispersivo e un percorso realmente orientato al risultato.
Con il manuale Edises e il videocorso online, ogni candidato può costruire una preparazione solida, consapevole e progressiva, trasformando un ambito complesso in un vantaggio competitivo reale.
Edises non offre semplici contenuti: offre un metodo, una guida e una strategia.
Scegliere questi strumenti significa investire in un percorso efficace, che valorizza il tempo di studio e accompagna il candidato fino al traguardo.